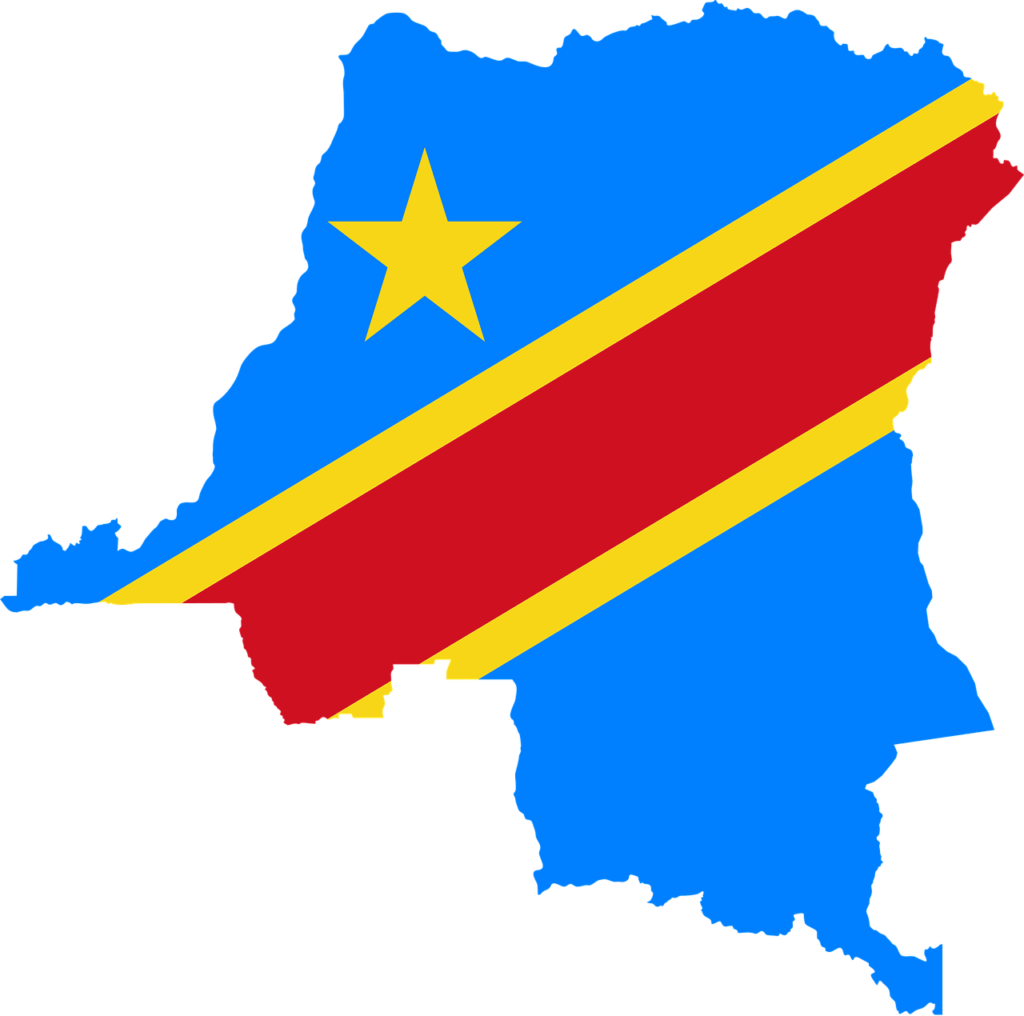Il 30 Marzo 2020 il Parlamento ungherese ha approvato una legge che dà i pieni poteri al presidente Orbán e al suo governo, giustificandola con la necessità di gestire in maniera efficace l’emergenza. Da questo momento in Ungheria il Governo ha facoltà di approvare le leggi senza passare per il Parlamento, possibilità di violare le leggi in vigore e sospendere le elezioni. Le nuove misure sono a tempo indeterminato e possono essere cancellate sono dal voto favorevole di 2/3 del parlamento e la firma del presidente. Lo stesso Parlamento è saldamente controllato dalla Fidesz, partito di cui Orbán è leader, che alle scorse elezioni del 2018 ha ottenuto 117 seggi su 199 e che assieme al suo alleato di Governo, il Partito Popolare Cristiano Democratico, controlla più dei due terzi dell’aula.
Le reazioni a livello europeo sono state immediate. I portavoce di molte ONG hanno denunciato questo come un colpo di stato istituzionale e invitato l’Europa a farsi sentire. La co-presidente del Comitato ungherese di Helsinki, una ONG molto attiva per il rispetto dei diritti umani nel paese, ha lanciato un monito: “La società civile, i giornalisti e le organizzazioni internazionali ed europee dovranno intensificare ulteriormente gli sforzi in questa nuova situazione per garantire che il potenziale di gravi abusi da parte del governo sia monitorato, documentato e risposto”.
Sul piano politico invece la reazione non è stata univoca, se le opposizioni ungheresi hanno denunciato un “colpo di stato”, l’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (gruppo politico di centro-sinistra del Parlamento Europeo) ha affidato la sua immediata risposta a un tweet: “con #COVID19 come copertura, il Primo Ministro Orbán sta smantellando la democrazia davanti ai nostri occhi. Governare indefinitamente con decreto o limitare la libertà dei media è una risposta misurata? A nostro avviso no.”
Il Partito Popolare Europeo (gruppo politico di centrodestra al Parlamento Europeo), a cui la Fidesz era iscritta ma sospesa all’epoca dei fatti, si fece trovare divisa al suo interno, facendo trapelare più di qualche imbarazzo per la gestione della questione. Alcuni leader conservatori, tra cui il primo ministro greco Mitsotakis, i conservatori di Belgio e Lussemburgo, un folto gruppo di leader scandinavi hanno firmarono una lettera in cui si richiese l’espulsione dal PPE del partito ungherese, ma a questa mancavano alcune firme notevoli come quella di Silvio Berlusconi per Forza Italia e dei partiti la CDU e CSU. Le politiche del leader della Fidesz non sono nuove a polemiche interne al PPE e non solo, spesso la coalizione euro-parlamentare si è trovata con tale questione in sospeso e ha spesso cercato di nascondere la polvere sotto il tappeto.
Si diceva, comunque, della sospensione. In effetti la Fidesz il 20 marzo 2019 è stata sospesa dal PPE, che significa non poter presentare suoi candidati, non avere diritto di voto in assemblea non poter nemmeno partecipare agli incontri del partito. Una misura chiesta da molto prima della sua attuazione da parte della coalizione a causa della continua deriva illiberale di Orbán e prolungata a febbraio 2020, poco prima del decreto emergenziale del governo ungherese. A giugno 2020, inoltre, la Fidesz ha annunciato l’autosospensione dei propri parlamentari dal PPE, in aperto contrasto con la linea del nuovo presidente dei Popolari, Donald Tusk, che rappresenta l’ala più liberale e centrista del partito.
Un po’ di storia.
Viktor Orbán è un politico di lungo corso e personaggio storico della politica ungherese. Entra in politica sulla scia delle rivoluzioni del 1989 e nel 1990 diventa leader della Fidesz, partito liberista ed europeista di centro-destra che, con Orbán a capo, inizia progressivamente a spostarsi verso posizioni conservatrici e nazionaliste fino a sfociare in una delle destre più radicali ed illiberali che esistano in questo momento in Europa. Alle elezioni parlamentari del 1998 il partito ottiene un importante numero di seggi e Orbán diventa primo ministro. Tra il 2002 e il 2010 perde due volte le elezioni e rimane il leader del principale partito di opposizione. Nel 2010 la sinistra è in piena crisi in Ungheria e la Fidesz vince le elezioni parlamentari con la più larga maggioranza da 20 anni a quella parte, ottenendo 263 seggi su 386. Al secondo governo Orbán ne seguiranno un terzo e un quarto (quello attuale), una lunga dominazione politica garantita anche da riforme costituzionali che hanno più volte suscitato polemiche a livello internazionale. L’ampia maggioranza di cui ha sempre goduto in Parlamento, ha permesso ad Orbán, già dal 2010 di avviare un processo di stesura di una revisione della Costituzione, approvata ad aprile dello stesso anno. Il nuovo testo ha inserito elementi di conservatorismo, sottolineando l’importanza della centralità della famiglia tradizionale – a discapito degli altri possibili nuclei familiari -, della cultura ungherese – penalizzando le altre -, dell’etica e della religione cattolica – penalizzando o addirittura mettendo al bando credi diversi dal cattolicesimo -.
Secondo molti analisti politici Viktor Orbán ha il controllo sostanziale e incontrastato del Paese dal 2011, anno in cui ha nuovamente stravolto la Costituzione con una serie di riforme che limitano le libertà ideologiche e il controllo indipendente sul potere, giustificandole politicamente come un processo di “purificazione dall’esperienza comunista”. Ha poi riformato l’istruzione e la libera informazione, creando una Commissione Governativa di Controllo Televisivo. La serie di revisioni costituzionali ha toccato anche il potere giudiziario, dando facoltà al presidente dell’Ufficio Giudiziario nazionale di individuare il magistrato che seguirà una certa causa e aprendo alla possibilità di trasferire di sede i giudici senza il loro consenso. La stessa riforma del 2011 ha posto il CSM Ungherese sotto il controllo del Governo e, come rivela uno studio del 2015 condotto da alcune ONG ungheresi e rilanciato da Liberties, riempiendo la maggioranza della corte Costituzionale di giudici nominati dalla maggioranza senza alcuna negoziazione con l’opposizione, annullando de facto la divisione dei poteri.
Al fine di mantenere saldo il suo potere, Orbán ha riformato la legge elettorale in vista delle elezioni del 2014, la quale, oltre a ridurre il numero dei parlamentari, ha introdotto una soglia di sbarramento al 10% per le coalizioni, riducendo al minimo il pluralismo politico e permettendo alla Fidesz di ottenere 133 seggi su 199 con il 44,54% dei voti.
Allo stesso modo è arrivata anche la stretta contro la comunità LGBT. Dopo aver dichiarato illegittimi i matrimoni egualitari nel 2012, nel 2018 sono stati proibiti gli studi di genere nelle università. Su questo solco si inserisce l’annullamento della possibilità per i transgender di cambiare sesso sul documento di identità e quindi non riconoscimento dell’unione etero per i transgender che si sposano con il sesso opposto, con conseguente impossibilità di accedere ai benefici per le famiglie. Va sottolineato come questa stretta sui diritti per le persone transgender sia stato il primo provvedimento attuato dal governo utilizzando i pieni per lo stato di emergenza pandemica.
Ora?
Il 16 giugno il Parlamento ha votato la revoca dello stato d’emergenza e dei poteri speciali in seno ad Orbán. Un atto con cui il governo ungherese ha puntato a smentire i dubbi europei sullo stato di diritto al fine di calmare le acque in ottica Recovery Fund, ma che per le opposizioni non è altro che un’“illusione ottica”. L’attacco è arrivato dalla minoranza parlamentare assieme ad alcune ONG, tra cui Amnesty e il Comitato Ungherese di Helsinky, che denunciano come nel provvedimento adottato vi sia la possibilità per il governo di dichiarare arbitrariamente e senza passare per il Parlamento un nuovo stato di emergenza e nuovi poteri speciali. Dagli stessi soggetti arriva anche l’allarme sui 180 decreti emanati dal Primo Ministro ungherese durante l’emergenza, la minor parte dei quali in materia sanitaria. Tra questi spiccano, oltre alla stretta sui diritti dei transgender, la diminuzione dei fondi alle città e ai comuni governati dall’opposizione (che alle ultime elezioni amministrative ha fatto registrare un exploit nella maggior parte dei seggi) per destinarli al governo centrale, la modifica al codice penale che inserisce una pena fino a 5 anni per chi diffonde fake news che, denunciano le ONG, è stata applicata anche a semplici cittadini che hanno espresso dissenso verso la politica del governo con un post sui social e che il giorno dopo hanno subito una perquisizione del domicilio da parte della polizia. Così come l’approvazione del controverso progetto per la ferrovia Budapest-Belgrado, un piano che getta ombra sui rapporti economici tra Pechino e l’élite economica ungherese (la stessa che finanzia la Fidesz e controlla la maggior parte dell’informazione), finanziata dalla Cina, con la quale l’Ungheria ha contratto un debito di 1,9 miliardi e i cui documenti sono stati secretati per 10 anni.
Come sottolineano gli analisti, quella di Orbán è stata solo una “prova di forza”. Grazie all’ampia maggioranza di cui gode in Parlamento, il governo ha fatto approvare, dal 2010 in poi, qualsiasi modifica ai codici o alla Costituzione tramite legge ordinaria, anche minando alcuni principi cardine dello stato di diritto. L’ottenimento dei poteri speciali dunque non è necessario e sul lungo periodo si sarebbe rivelato rischioso, in questo modo invece Orbán è riuscito ad affermare che le voci sulla deriva autoritaria del suo governo fossero sbagliate ed ha al contempo ha mostrato i muscoli a tutti coloro che gli si oppongono, dimostrando che se vuole può ottenere poteri illimitati quando e come dice lui. Intanto, come da 10 anni a questa parte, Orbán continua a fare quello che gli pare.
“E l’Europa?”
Il rapporto “complicato” tra l’Ungheria di Orbán e l’Unione Europea
All’Unione Europea viene diffusamente contestato un ruolo passivo nella gestione dell’ascesa al potere incontrollato da parte di Orbán, sebbene una serie di procedure di infrazione siano state aperte nei confronti dell’Ungheria negli ultimi anni, nessuna azione europea ha avuto ricadute concrete nella politica interna del governo.
Nel 2012 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Ungheria relativamente all’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici e all’indipendenza dell’autorità garante della protezione dei dati. L’allarme era scattato nel 2011, a seguito dell’approvazione della prima riforma della Costituzione, con la Commissione che ha ravvisato anche altre infrazioni, riguardo la non indipendenza della banca centrale ungherese e alla mancata indipendenza della magistratura. Oltre alla violazione di alcuni principi della Carta Fondamentale dell’UE (che però non comportano l’apertura di procedure di infrazione).
Nel 2018 il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza la risoluzione che contesta all’Ungheria la violazione dello stato di diritto nel campo della magistratura, dei media, della libertà accademica, della libertà religiosa, della protezione delle minoranze e della possibilità di operare per le ONG e per la società civile.
Anche nel 2019 l’Ungheria ha visto aprirsi una procedura di infrazione nei suoi confronti, questa volta a causa della legge “stop-Soros” (dal cognome del filantropo attivo nel campo dei diritti umani che Orbán ha più volte individuato come “nemico dell’Ungheria”), che criminalizza le attività a sostegno dei richiedenti asilo e a causa del rifiuto da parte di autorità del paese di dare a persone in attesa di rimpatrio che si trovano nelle aree di transito ungheresi al confine con la Serbia. Qusta del 2019 è stata una prima risposta a una politica migratoria aggressiva da parte dell’Ungheria che, a partire dal 2015, ha rifiutato l’assegnazione di quote obbligatorie di migranti, sistematicamente respinto con la forza i richiedenti asilo al confine con la Serbia e spinto per l’allargamento della lista dei paesi sicuri, tra cui avrebbe voluto inserire anche la Turchia. Di fatto schierandosi contro una soluzione della questione migratoria ma facendo rimbalzare il problema sugli altri paesi dell’Unione.
Nessuna procedura invece è partita in risposta alla legge che il 30 marzo diede i pieni poteri a Orbán, questo perché l’Europa ha le armi spuntate. Sia perché nella Costituzione ungherese è prevista la possibilità, in caso di emergenza, di attuare questa fattispecie, sia perché in caso di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE è prevista l’espulsione, ma non sanzioni intermedie. Negli anni le varie procedure di infrazione e i vari tagli dei fondi strutturali che sono stati inflitti all’Ungheria non hanno scalfito il potere della Fidesz, ma l’Unione Europea non può espellere l’Ungheria. Non va dimenticato che l’Ungheria è un paese il cui peso geopolitico sta crescendo e, lo si è visto specialmente nelle ultime trattative per il Recovery Fund, sta diventando sempre più leader dell’area balcanica. Inoltre la Fidesz è membro di una delle più grandi coalizioni del Parlamento Europeo: il PPE, che, pur professandosi liberale ed europeista, non ha mai espulso il partito di Viktor Orbán. Una politica attendista che, alla luce della situazione attuale, non sembra aver dato i risultati sperati per l’UE.
D’altro canto appare chiaro che l’Ungheria e Viktor Orbán hanno bisogno dell’UE. Nonostante il mantra che il Primo Ministro ripete periodicamente sia “non accettiamo giudizi sulla nostra democrazia da parte dell’UE”, la sua strategia politica è un continuo rimbalzo tra due poli. Uno pubblico e apertamente euroscettico, con cui nutre il suo consenso, attaccando i principi liberali europei e addossando all’Unione una serie di responsabilità e di mancanze, identificandola come una sorta di nemico sempre attivo sotto traccia, pronto ad attaccare il popolo ungherese da un momento all’altro. Il secondo polo è istituzionale, alla ricerca di una continua pacificazione con l’Europa, i cui fondi sono necessari per lo sviluppo economico del paese, in particolare in direzione green. L’Ungheria si vede assegnata una delle fette più sostanziose del Just Transition Mechanism, il fondo varato all’interno dello European Green Deal, a sostegno delle economie più dipendenti da fonti fossili e che quindi potrebbero essere danneggiate nella corsa al raggiungimento degli obiettivi climatici.
Insomma, seguendo la logica “sì all’Europa e ai suoi soldi, no ai suoi valori liberali”, la battaglia più recente non può che essersi combattuta sul campo delle negoziazioni per il Recovery Fund, concludendosi con un sostanziale pareggio. Nell’accordo si legge che l’erogazione dei fondi del piano sarà legata alla tutela dello stato di diritto, una clausola che suona come un chiaro avvertimento all’Ungheria, che tuttavia rimane una formula vaga, e non si sa ancora in che misura verrà applicata.
In quella che sembra una lenta partita a scacchi in cui conta ogni sguardo, l’Europa rischia di perdere a causa del gioco di alleanze continentali che Viktor Orbán riesce con efficacia a portare avanti. Ma a scacchi non si vince chiudendo un occhio.
di Alessandro Ceschel