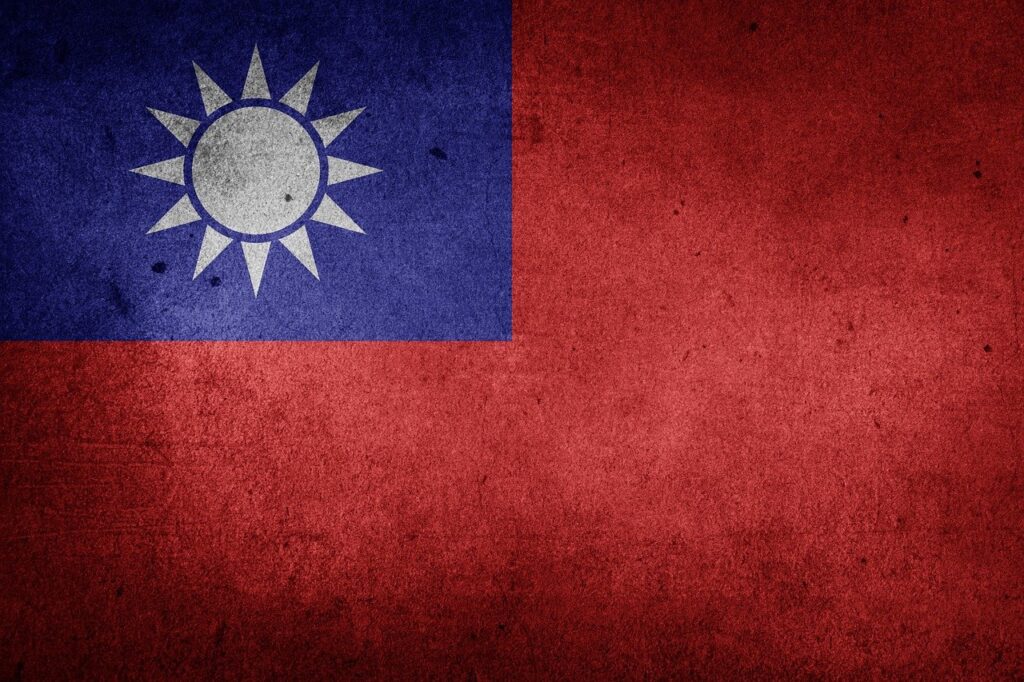La storia del Sudafrica dell’Apartheid è la storia di un’appassionata e inarrestabile lotta per la libertà.
Ci sono le vittime e i carnefici, gli oppressi e gli oppressori. Ci sono milioni di sudafricani che non
hanno mai conosciuto la libertà, senza, però, perdere la speranza. Comprendere come sia stato
possibile, sul finire del secolo scorso, smantellare questo sistema è testimonianza dell’importanza
della conoscenza della storia per la comprensione del presente e la pianificazione del futuro.
Questo sistema di discriminazione e oppressione ha lasciato un segno indelebile nella storia del
Paese e ha avuto profonde ripercussioni sulla società, sulla politica e sulla cultura del Sudafrica
contemporaneo. L’Apartheid, parola derivante dalla lingua afrikaans, il cui significato è
“separazione”, vede le sue origini nella particolare idea segregativa formatasi con la creazione
dell’Unione Sudafricana nel 1910, anche se le sue radici erano da secoli radicate nel tessuto sociale
del Paese.
Sin dal diciassettesimo secolo, con l’arrivo degli Europei nel territorio della penisola del Capo, ebbe
inizio, infatti, un processo di colonizzazione che portò ad uno scontro tra diverse culture, etnie e
interessi politici ed economici. Tuttavia, solo a partire dal 1948, con la vittoria delle elezioni da parte
del National Party, partito rappresentante gli interessi della popolazione Afrikaner, l’Apartheid in
quanto tale vedrà la sua istituzionalizzazione vera e propria, andando a sostituire, secondo uno
schema maggiormente efficiente ed innovativo, la politica segregazionista attuata nella prima metà
del secolo. Si delineò così un continuum all’interno del quale vennero introdotti nuovi strumenti di
controllo e contenimento degli Africani, tra i quali i bantustan, nel linguaggio governativo
homelands, che avrebbero dovuto costituire i territori nei quali segregare le etnie nere. Sarà allora
proprio dal momento della sua ascesa al potere che il National Party poté strutturare la legislazione
discriminatoria basata sull’appartenenza razziale che rappresentava il “cuore” dell’Apartheid,
andando a scardinare definitivamente i diritti civili, economici e politici della componente nera.
L’interazione tra le varie componenti razziali del Paese, la battaglia tra oppressi e oppressori e,
infine, la composizione degli storici contrasti nella costruzione di un “nuovo Sudafrica”,
costituiscono una preziosa lezione di lotta per la libertà, per la democrazia e per i diritti umani: una
lectio magistralis dell’umanità in termini di tolleranza e risoluzione pacifica dei conflitti.
Uno dei principali risultati emersi dall’analisi di questa complessa fase storica è il riconoscimento
del regime di Apartheid come un sistema di discriminazione razziale dai contorni estremamente
sfumati e complessi: la segregazione istituzionalizzata, infatti, unita alla soppressione di diritti e
libertà, ha permeato tutti gli aspetti della vita quotidiana dei Sudafricani, creando divisioni
profonde, talvolta apparse insanabili, tra i diversi gruppi presenti nel Paese.
L’Apartheid, però, non ha riguardato solo la segregazione fisica e legale, è stato anche un sistema di
controllo sociale e psicologico in quanto la politica governativa ha cercato di giustificare la
segregazione attraverso l’ideologia della superiorità razziale che postulava la preminenza della
“razza bianca” sulla base di una fittizia gerarchia biologica. Questa ideologia è stata utilizzata per
giustificare l’oppressione della popolazione africana e per legittimare la discriminazione sistematica
di cui il Paese era permeato. Verso la metà degli anni Settanta, però, il segno del fallimento di questa
politica iniziava ad essere progressivamente più evidente, tanto da mostrare la possibilità
dell’apertura di negoziati tra le parti che, dal decennio successivo, sarebbero stati portati a
compimento permettendo la realizzazione del difficile processo di transizione democratica verso un
Sudafrica post-Apartheid.
Altro punto chiave che emerge dalla comprensione di questo capitolo storico riguarda il ruolo
fondamentale della resistenza e dell’attivismo nel porre fine all’Apartheid. Sia all’interno del
Sudafrica che a livello internazionale, le proteste, le manifestazioni, le sanzioni economiche e la
pressione politica hanno svolto un ruolo cruciale nel minare il sistema segregazionista e spingere il
governo sudafricano ad intraprendere una negoziazione pacifica.
La fine della dominazione razziale è stata un momento storico unico, contrassegnato dall’ascesa di
Nelson Mandela alla presidenza e dalla promulgazione di una nuova Costituzione inclusiva che
consentiva al Paese di uscire dall’esperienza di divisione ed emarginazione sociale e politica che per
lungo tempo lo aveva caratterizzato. Questo processo è stato possibile grazie alla compresenza di
molteplici fattori che, intersecandosi sul piano sociale, politico ed economico, hanno permesso il
superamento dell’ultimo ostacolo per il raggiungimento di un’Africa libera. È stato proprio a partire
dai primi anni Settanta che il governo sudafricano si è ritrovato ad affrontare una situazione interna
sempre più instabile, in cui l’ingestibile urbanizzazione, la crescente militanza sociale e la grave crisi
economica sulla quale agiva la comunità internazionale, ponevano le basi per le prime riflessioni
all’interno del regime. Nello stesso periodo era stata messa in moto, dopo anni di strategico
immobilismo, una diplomazia internazionale che avrebbe dovuto trovare valide soluzioni alle
controversie insite nella regione, ed inoltre, il governo sudafricano, iniziava a sentirsi
progressivamente più vulnerabile a causa dell’indipendenza, di matrice marxista, raggiunta da
Angola e Mozambico la quale, ponendo fine all’irriducibile colonialismo portoghese, rendeva il
Sudafrica sempre più isolato nel panorama dell’Africa australe.
Progressivamente l’Apartheid era divenuto quindi insostenibile e, in questo senso, le dinamiche
globali della politica rappresentavano l’acceleratore di un processo apparso ormai inesorabile.
L’espansione su scala mondiale dei principi democratici, dei diritti umani e dell’uguaglianza,
pertanto, ha condotto numerosi Paesi a riflettere sulla situazione sudafricana e, in generale, sulla
scelta di instaurare relazioni con un regime interamente fondato sulla segregazione razziale.
L’obiettivo intrinseco della presente analisi è altresì volto a dimostrare come, nonostante l’uscita
dall’atroce esperienza della segregazione e dell’emarginazione razziale, il Sudafrica rimanesse
afflitto da molteplici questioni irrisolte. La difficoltà di raggiungere una riconciliazione nazionale
autentica, la disparità nell’allocazione delle risorse economiche e le iniquità persistenti
rappresentano ancora oggi nodi problematici nella trama sociale sudafricana.
Questa analisi evidenzia, pertanto, come il sistema dell’Apartheid abbia lasciato cicatrici troppo
profonde nel tessuto sociale del Paese, trasmettendo un’eredità persistente che richiede ulteriori
sforzi per essere affrontata in modo completo e definitivo. La giustizia sociale, l’uguaglianza
economica e l’educazione equa rappresentano solo alcune delle complessità saldamente radicate
nel Sudafrica contemporaneo. Tuttavia, nonostante le numerose difficoltà, le incertezze e le sfide
ancora da affrontare, è inevitabile riconoscere l’eccezionale impresa realizzata.
L’Apartheid ha indubbiamente costituito uno dei capitoli più bui nella storia del Paese, ma allo stesso
tempo ha rappresentato una testimonianza della resilienza umana e della capacità di influenzare il
corso degli eventi. La comprensione di questo complesso capitolo storico consente di riflettere sul
passato, apprezzare i progressi raggiunti ed impegnarsi per un futuro più equo ed inclusivo.
L’avvento del Sudafrica post-Apartheid può essere definito un miracolo nel senso che raramente tali
transizioni avvengono con successo, soprattutto in contesti segnati da una lunga storia di conflitti.
Il caso sudafricano in questo senso, con le sue peculiarità, assume un carattere unico nella storia
dell’umanità. Un successo che non avvenne improvvisamente, né automaticamente. Fu un processo
spalmato nell’arco di tre decenni, originato da fattori di varia natura, ma che, infine, ha permesso di
comprendere come l’oppressore sia schiavo almeno quanto l’oppresso, perché prigioniero dell’odio,
del pregiudizio e dell’etnocentrismo.
La tormentata storia sudafricana ci insegna proprio questo: l’oppressore e l’oppresso sono entrambi
derubati della propria umanità.
A cura di Gaetano Modafferi
Bibliografia e letture consigliate:
De Klerk Frederik Willem, The Last Trek: A New Beginning, Macmillan, Londra 1998.
De Klerk Willem, F. W. de Klerk: The Man in His Time, Jonathan Ball Publishers, Johannesburg 1991.
Ellis Stephen, The Genesis of the ANC’s Armed struggle in South Africa 1948-1961, Journal of Souther
African Studies, Vol. 37, No. 4, dicembre 2011.
Gentili Anna Maria, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana, Carrocci editore, Città di
Castello 2019.
George Edward, The Cuban Intervention in Angola, 1965-1991: From Che Guevara to Cuito
Cuanavale, Routledge Books, Londra 2005, parte di Cass Military Studies.
Greffrath Wynand, The Demise of post-apartheid and the emergence of post-colonial South Africa,
Journal of Contemporary History, Vol. 41, No. 2.
Kuper Leo, Passive Resistance in South Africa, Jonathan Cape, Londra 1956.
Lollini Andrea, Storia e diritto nella Commissione sudafricana “verità e riconciliazione”,
Contemporanea, Il Mulino, Vol. 12, No. 1, gennaio 2009.
Mandela Nelson, Lungo cammino verso la libertà, Autobiografia, traduzione di Bottini Adriana,
Dornetti Ester e Papi Marco, Universale Economica Feltrinelli, ventiseiesima edizione, Milano 2022.
Mandela Nelson, Un ideale per cui sono pronto a morire, a cura di Roberto Merlini, Garzanti Libri,
Milano 2013.
Mandela Nelson, Un mondo senza apartheid, traduzione di Maffi Marcella, Gruppo Editoriale
L’Espresso S.p.A, Roma 2011.
Revell Anna, Apartheid. A History of Apartheid, Torrazza Piemonte (TO) 2017.
Thompson Leonard, A History of South Africa, Yale University Press, rivisto ed aggiornato da Berat
Lynn, Fourth Edition, New Haven 2014.
Welsh Frank, A History of South Africa, Harper Collins, Londra 1998
Foto di WikiImages da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/discriminazione-razzismo-colorato-60512/)