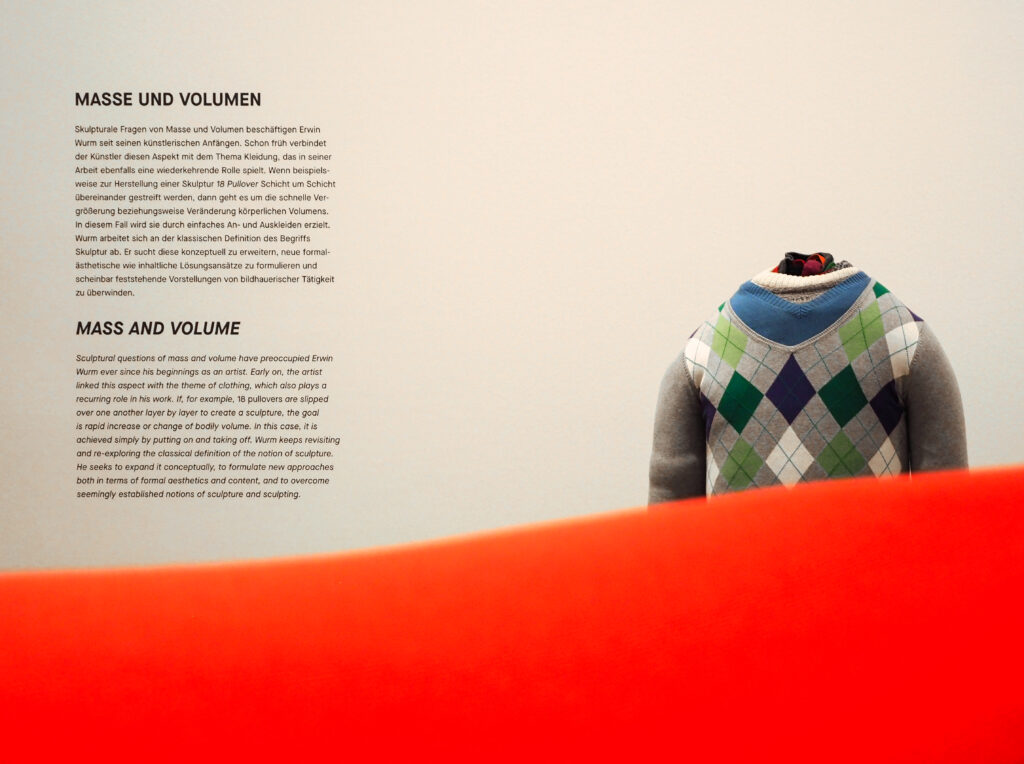- Storia del caso
Le Parti del giudizio sono: la sig.ra Tjebbes, nata a Vancouver (Canada) il 29 agosto 1984, cittadina dalla nascita sia dei Paesi Bassi che del Canada; la sig.ra Koopman, nata a Hoorn (Paesi Bassi) il 23 marzo 1967, cittadina fin dalla nascita dei Paesi Bassi e, con il matrimonio, anche svizzera; la sig.ra Saleh Abady, nata a Teheran (Iran) il 25 marzo 1960, cittadina iraniana per nascita ed olandese per regio decreto del 3 settembre 1999; la sig.ra Duboux, nata a Losanna (Svizzera) il 13 aprile 1995, cittadina sia elvetica che olandese (per via della differente nazionalità dei genitori). Da far presente che quest’ultima Parte, durante la sua minore età, è stata iscritta nel passaporto olandese della madre, rilasciato il 10 luglio 2000 e valido sino al 10 luglio 2005.
Le Parti hanno in comune il fatto che ognuna ha presentato richiesta di rinnovo del Passaporto olandese presso le autorità competenti e che il ministro ha rifiutato di esaminare le domande contestando che le richiedenti avevano perso ipso iure la cittadinanza dei Paesi Bassi, a norma dell’art. 15, par. 1, lett. c), o dell’art. 16, par. 1, lett. d) della legge sulla cittadinanza.
Avverso la decisione di cui sopra, le ricorrenti nel procedimento principale hanno avanzato, ognuna per sé, ricorso dinanzi al Tribunale dell’Aia. Successivamente, tale Tribunale ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dalle sig.re Tjebbes, Koopman e Saleh Abady, dichiarando invece fondato il ricorso della sig.ra Doboux e annullato la decisione del ministro adottata nel merito, pur disponendo il mantenimento degli effetti giuridici di tale decisione.
Le Parti hanno proposto appello dinanzi a queste sentenze al Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Tale organo giurisdizionale è stato interpellato per verificare se “la perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce della sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann”. L’organo di cui sopra ha ritenuto “che tali articoli si applichino alla causa di cui al procedimento principale, anche se, in tale causa, la perdita dello status di cittadino dell’Unione risulta dalla perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e non da una decisione individuale esplicita che ha per effetto la revoca del la cittadinanza, come nel caso all’origine della citata sentenza”. Inoltre, il Consiglio di Stato olandese ritiene che il legislatore nazionale non abbia agito arbitrariamente adottando l’art. 15, par. 1, lett. c.), della legge sulla cittadinanza e non abbia quindi violato l’art. 7 della Carta, riguardante il rispetto della vita privata e familiare, ma tuttavia ritiene che non sia certo che un regime legale generale, come quello previsto dalla legge sulla cittadinanza, sia conforme agli artt. 20 e 21 TFUE. Viene rilevato, sempre dall’autorità giurisdizionale di rinvio, che l’art. 16, par. 1, lett. d, della legge sulla cittadinanza riflette l’importanza che il legislatore ha attribuito all’unità della cittadinanza all’interno della famiglia. Si domanda allora “se sia proporzionato revocare a un minorenne lo status di cittadino dell’Unione, e i diritti ad esso correlati, unicamente al fine di preservare l’unità della cittadinanza all’interno della famiglia, e quale peso abbia al riguardo l’interesse superiore del minore di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta”, rilevando che la conformità dell’art. 16, par. 1, lett. d), della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi con il principio di proporzionalità non sarebbe chiaramente dimostrata, visto che il minore può fare ben poco per interrompere il decorso di alcuni termini per mantenere la cittadinanza olandese.
Per questa ragione, il Consiglio di Stato olandese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- La questione pregiudiziale
La questione che il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di giustizia è la seguente:
«Se gli articoli 20 e 21 [TFUE], anche alla luce dell’articolo 7 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, a causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità e riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per la situazione dell’interessato sotto il profilo del diritto dell’Unione, essi ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che stabiliscono:
- a) che un maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto la sua residenza principale all’estero e al di fuori dell’Unione europea, mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni;
- b) che un minorenne, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al (…) punto a».
- L’analisi del contesto normativo da parte della Corte di giustizia
Le normative che sono state analizzate dalla Corte di giustizia per la soluzione del presente caso sono state:
- Con riferimento al diritto internazionale: gli artt. 6 (“Se la legge di uno Stato contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all’acquisizione di un’altra cittadinanza”) e 7 parr. da 3 a 6 (quest’ultimo sancisce che “Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione”) della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia; l’art. 7 della Convenzione europea sulla cittadinanza.
- Con riferimento al diritto dell’Unione: l’art. 20 TFUE (al primo comma sancisce che “E’ istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”); l’art. 7 (“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”) e l’art. 24, par. 2 (“In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti di autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”) della Carta.
- Con riferimento al diritto dei Paesi Bassi: gli art. 6, par. 1, lett. f), 7 (elenca le fattispecie per le quali un maggiorenne può perdere la cittadinanza olandese, ad esempio nel caso in cui, con una cittadinanza straniera e nella maggiore età, per un periodo ininterrotto di dieci anni, si abbia la residenza principale al di fuori dei Paesi Bassi e fuori dai territori in cui è applicabile il Trattato UE, facendo presente che tale periodo “è interrotto dal rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi o di un documento di viaggio o di carta d’identità dei Paesi Bassi ai sensi della legge sui passaporti” e che “dal giorno del rilascio inizia a decorrere un nuovo periodo di dieci anni”), e 16 (elenca le fattispecie in cui un minore perde la cittadinanza dei Paesi Bassi, compreso il caso in cui nessuno dei due genitori possiede la cittadinanza olandese) della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi; l’art. IV (che sancisce che “il periodo di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della legge sulla cittadinanza comincia a decorrere non prima del 1° aprile 2003”) della legge recante la modifica della norma sulla cittadinanza dei Paesi Bassi (acquisizione, concessione e perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi) del 21 dicembre 2000.
- L’analisi del caso da parte della Corte di giustizia
Innanzitutto, la Corte di giustizia rileva che non occorre rispondere alla questione sollevata in merito all’art. 21 TFUE perché, dalla decisione di rinvio “non emerge che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione”. Inoltre, la Corte rammenta che “il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi devono rispettare quest’ultimo”, derivando questo principio dalla precedente sentenza Rottmann. Rileva che l’art. 20 TFUE “conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri” e che, di conseguenza, la situazione dei cittadini che posseggono la cittadinanza di un solo Stato membro dell’Unione e con la perdita di questa si trovano senza lo status di cui al sopracitato articolo, “ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione”. Di conseguenza gli Stati membri, nell’esercizio di questa competenza, devono rispettare il diritto dell’Unione.
In riferimento alle osservazioni presentate dal governo dei Paesi Bassi, dove viene fatto presente che “uno degli obiettivi della legge sulla cittadinanza è impedire che ottengano o mantengano la cittadinanza dei Paesi Bassi persone che non abbiano o non abbiano più un legame con il Regno dei Paesi Bassi” e che l’obiettivo dell’art. 16, par. 1, lett. d), di tale legge, consisterebbe nel ripristinare l’unità della cittadinanza all’interno della famiglia, la Corte di giustizia, insieme all’Avvocato generale ritengono legittimo, “per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza” ed anche “che uno Stato membro voglia tutelare l’unità della cittadinanza all’interno di una stessa famiglia”.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il criterio di cui all’art. 15, par. 1, lett. c) della legge sulla cittadinanza, che prevede la residenza per un periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori dei Paesi Bassi e dei territori in cui è applicabile il Trattato UE, mostri l’assenza di questo legame effettivo. È possibile considerare anche che tale concetto si estende all’art. 16, par. 1, lett. d) della stessa legge, che prevede che l’assenza di legame effettivo tra i genitori di un minore e il Regno dei Paesi Bassi implichi, in linea di principio, l’assenza di tale legame tra detto minore e detto Stato membro.
Inoltre, la Corte ritiene che, nel caso di specie, il rischio di apolidia sia escluso dalle disposizioni olandesi di cui al procedimento principale, dato che “la loro applicazione è subordinata al possesso da parte dell’interessato, oltre che della cittadinanza dei Paesi Bassi, di quella di un altro Stato”. Inoltre, rileva che l’art. 7, par. 1, lett. e) e par. 2 della Convenzione sulla cittadinanza sancisce la possibilità che lo Stato membro possa prevedere la perdita della propria cittadinanza quando, nel caso di un maggiorenne, sia assente qualunque legame effettivo tra tale Stato e un cittadino che risiede abitualmente all’estero e, nel caso di un minore, per il figlio i cui i genitori perdano la cittadinanza di detto Stato.
In virtù di quanto sopra, la Corte ha osservato, riprendendo il caso Rottmann, che la perdita per legge della cittadinanza di un Paese membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità qualora le norme nazionali non permettessero in alcun momento “un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell’Unione”. Da ciò ne consegue che, nella situazione di cui al procedimento, “le autorità e gli organi giurisdizionali competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far riacquistare ex tunc la cittadinanza all’interessato, in occasione della domanda, da parte di quest’ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza”.
Tale esame, ad avviso della Corte, richiede una valutazione della situazione individuale dell’interessato e dalla sua famiglia per determinare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato comporti conseguenze “che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell’Unione” avvertendo che “siffatte conseguenze non possono essere ipotetiche o eventuali”.
Le autorità nazionali competenti (nonché gli organi giurisdizionali) dovranno assicurarsi che “una siffatta perdita di cittadinanza sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta di cui la Corte ne assicura il rispetto, e più precisamente, al diritto al rispetto della vita familiare”, ai sensi dell’art. 7 della Carta, letto in combinato disposto con l’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore, di cui all’art. 24, par. 2, della Carta.
La Corte avverte che a seguito della perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi e dello status di cittadino dell’Unione, “l’interessato sarebbe sottoposto a limitazioni nel suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività”. Aggiunge che “sono altresì rilevanti, da un lato, il fatto che l’interessato non avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e, per questo, gli si applica l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e, dall’altro, il serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di movimento al quale sarebbe esposta la persona interessata dell’impossibilità di beneficiare, sul territorio dello Stato terzo in cui tale persona risiede, della protezione consolare ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE”.
- La pronuncia
Per le motivazioni di cui sopra, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha pronunciato che: “L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comportante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione”.
In aggiunta alla precedente sentenza Rottmann, la sentenza Tjebbes subordina la conformità di qualsiasi legge nazionale che preveda la revoca della cittadinanza, ad un esame, caso per caso, della situazione della Parte.
A cura di: Antonio Natale
Fonti
- “Elementi di diritto dell’Unione Europea” di Adelina Adinolfi e Claudia Morviducci, Ed. Giappichelli.
- Sentenza Tjebbes: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FF6111290DA9B0893B32709CB4C0AA06?text=&docid=211561&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1591998
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
- Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
- Per l’immagine: Foto di Ralphda Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/striscione-bandiera-europa-3370970/).