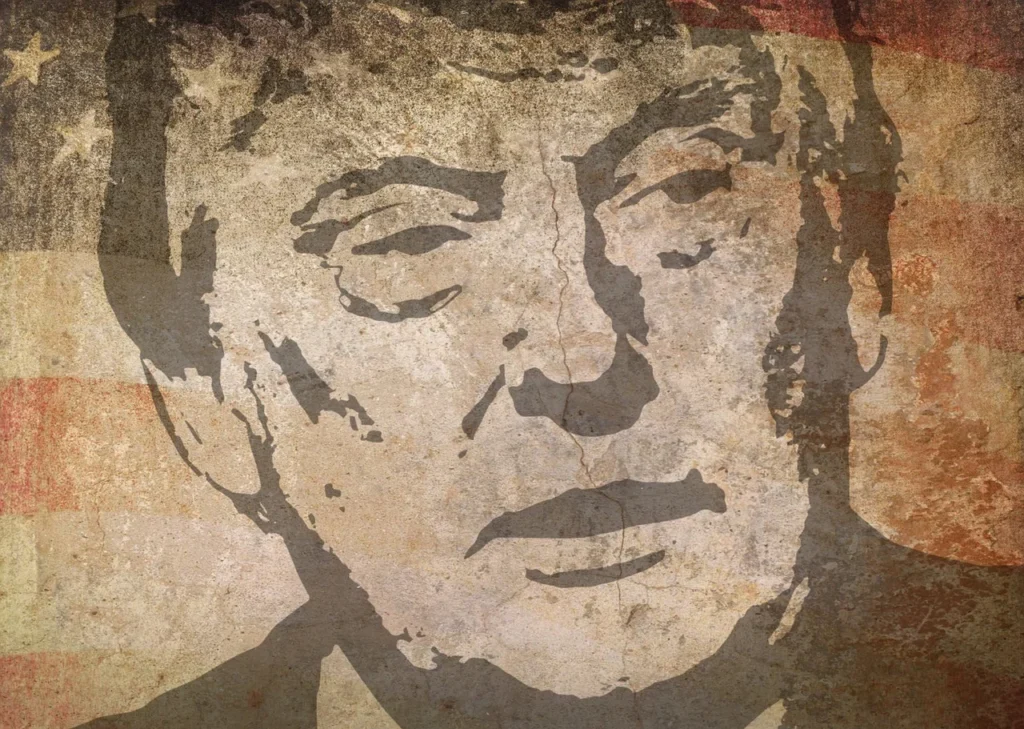Premessa
L’art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sancisce, al primo comma, che “È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” e che “La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”. Al comma 2 del sopracitato articolo, sono elencati, seppure in maniera non esaustiva, alcuni importanti diritti che godono i cittadini dell’Unione Europea, quali quelli di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, il diritto al voto per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo e alle elezioni comunali dello Stato membro in cui risiedono, il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche di un qualsiasi Paese membro in uno Stato terzo, quando non è presente la rappresentanza del proprio Paese. Da non dimenticare anche il diritto di petizione al Parlamento europeo, di ricorso al Mediatore europeo e il diritti a rivolgersi alle istituzioni ed organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Cosa ne consegue da ciò? Che la cittadinanza dell’UE può essere acquisita solo essendo cittadini di uno Stato membro. Ne discende che gli Stati membri rimangono competenti nella determinazione dei criteri di conferimento della cittadinanza nazionale, che permette in automatico l’acquisizione della cittadinanza europea. È doveroso sottolineare che, una volta attribuita la cittadinanza europea, essa è soggetta alla normativa dell’Unione. La qualifica di cittadinanza “aggiuntiva”, risultante dall’art. 20 TFUE, anziché́ “complementare” è stata interpretata, da una parte della dottrina, come un importante sviluppo dell’istituto in esame, in quanto separerebbe la cittadinanza europea da quella nazionale, di cui non sarebbe più̀ un completamento, ma la configurerebbe come una vera e propria seconda cittadinanza, dotata di “autonomia di status”.
Bisogna aggiungere la possibilità, per ogni Stato membro, di indicare chi, tra i propri cittadini, deve essere considerato cittadino dell’Unione. Questo si può verificare, per esempio, nel caso di Stati che concedono la propria cittadinanza non pleno iure a persone originarie di paesi ex colonie di alcuni stati dell’UE .
- Storia del caso
Il ricorrente, il sig. Rottmann, è nato a Graz, in Austria, quindi, in origine, cittadino austriaco. Nel 1995 trasferisce il proprio domicilio a Monaco di Baviera. La particolarità è che questo trasferimento avviene dopo essere stato sentito dal Tribunale regionale per le cause penali di Graz, nell’ambito di un’inchiesta avviata nei suoi confronti per il sospetto – da lui respinto – di truffa aggravata nell’esercizio della sua professione. Due anni dopo, nel febbraio del 1997, lo stesso Tribunale emette un mandato di arresto nazionale nei confronti di Rottmann. Quest’ultimo, nel 1998, chiede la cittadinanza tedesca, omettendo di menzionare le azioni penali avviate nei suoi confronti in Austria, ed ottiene, in data 5 febbraio 1999, il rilascio dell’atto di naturalizzazione, la quale ha comportato la perdita della cittadinanza austriaca.
Nel 1999, la città di Monaco di Baviera viene informata dell’azione penale nei confronti di Rottnam dalle Autorità municipali di Graz e dal Pubblico Ministero austriaco. Alla luce di quanto sopra, il Freistaat Bayen, o Baviera, uno dei 16 Stati federati della Germania, il 4 luglio 2000, dispone la revoca della naturalizzazione, con effetto “ex tunc”, ossia immediato, per ottenimento illecito della cittadinanza tedesca. Tale revoca, però, non divenne effettiva, a motivo del ricorso di annullamento proposto dal sig. Rottmann nella causa principale. Successivamente, la Corte Amministrativa del Land Baviera decise la non contrarietà alla revoca della naturalizzazione al diritto tedesco, anche nel caso in cui il provvedimento, una volta divenuto definitivo, rendesse apolide l’interessato. Il 25 ottobre 2005, Rottman presentò un nuovo ricorso presso la Corte Suprema Amministrativa, avverso quest’ultima decisione.
- Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Suprema Amministrativa tedesca alla Corte di Giustizia sono state le seguenti:
1) Se il diritto comunitario osti alla conseguenza giuridica della perdita della cittadinanza dell’Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati), anche se tale condizione derivi da una decisione legittima, come è stata la revoca della naturalizzazione come cittadino tedesco, in quanto ottenuta con la frode, perchè nel caso specifico, tale decisione, in combinazione con la normativa nazionale sulla cittadinanza dell’altro Stato membro coinvolto, l’Austria, ha prodotto l’effetto di rendere apolide l’interessato, a seguito della mancata reviviscenza dell’originaria cittadinanza austriaca.
2) Nel caso in cui la prima questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro (…) che ha naturalizzato il cittadino dell’Unione e che intende revocare la naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento debba, nel rispetto del diritto comunitario, astenersi totalmente o temporaneamente da tale revoca, qualora o fintanto che quest’ultima abbia come giuridica conseguenza (…) la perdita della cittadinanza dell’Unione, oppure se lo Stato membro (…) della precedente cittadinanza sia tenuto, nel rispetto del diritto comunitario, ad interpretare ed applicare o anche a modificare il proprio diritto nazionale in modo da evitare il prodursi della suddetta conseguenza.
Tali questioni pregiudiziali derivano da due premesse fatte dal Giudice remittente: la prima, derivante da una lettura di un’altra sentenza (la Micheletti), nella quale non è sufficientemente chiaro se lo status di apolide e la perdita della cittadinanza dell’Unione regolarmente acquisita in un momento precedente, determinata dalla revoca di una naturalizzazione, siano compatibili con il diritto dell’Unione. La seconda premessa riguarda, invece, la normativa austriaca: si chiede se la Repubblica d’Austria sia tenuta o meno ad interpretare ed applicare le proprie norme nazionali, ovvero ad adattarle in modo tale da evitare che l’interessato divenga apolide qualora egli – come nel caso in specie – non sia stato autorizzato a conservare lapropria cittadinanza di origine a seguito dell’acquisizione di una cittadinanza straniera.
- L’analisi normativa da parte della Corte di giustizia
Le normative che sono state analizzate dalla Corte di giustizia per la soluzione del presente caso sono state le seguenti:
- Con riguardo al diritto dell’Unione europea, la dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro, allegata dagli Stati membri all’Atto finale del Trattato sull’Unione europea e la sezione A della decisione dei Capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo di Edimburgo dell’11 e 12 dicembre 1992, che sancisce il carattere complementare della cittadinanza dell’Unione rispetto alla cittadinanza degli Stati membri.
- Con riguardo alla normativa tedesca, l’art. 16, n. 1 della Costituzione tedesca, il quale recita che “Nessuno può essere privato della cittadinanza tedesca di cui sia in possesso; la perdita della cittadinanza può verificarsi soltanto in forza di una legge e, qualora intervenga contro la volontà dell’interessato, soltanto se questi non divenga apolide in virtù di tale fatto”. L’art. 8 della legge sulla cittadinanza (nel testo applicabile fino al 31 dicembre 1999); il fatto che la naturalizzazione dello straniero era subordinata in linea di principio alla rinuncia o alla perdita della cittadinanza precedente; l’art. 48, nn. 1 e 2, della legge generale sul procedimento amministrativo del Land Baviera.
- Con riguardo alla normativa austriaca, l’art. 27, n. 1, della legge sulla cittadinanza (“Chiunque abbia ottenuto, a seguito di sua istanza, dichiarazione o espresso consenso, una cittadinanza straniera, incorre nella perdita della cittadinanza austriaca, salvo che egli sia stato preventivamente autorizzato a mantenerla”); l’art. 28, n. 1 della legge sulla cittadinanza (che prevede casi di mantenimento della cittadinanza austriaca); le osservazioni del governo austriaco che la perdita della cittadinanza straniera acquisita per naturalizzazione non comporti automaticamente che l’interessato recuperi retroattivamente la cittadinanza austriaca; l’art. 10 della legge sulla cittadinanza (che elenca le condizioni per la concessione della cittadinanza ad uno straniero).
- Con riguardo al diritto internazionale, l’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (dove si prevede il diritto di ogni individuo ad una cittadinanza e che nessuno può essere privato di questa e nemmeno del diritto di mutare cittadinanza), gli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia; gli artt. 3 (che prevede la competenza di ciascuno Stato stabilire, con la propria legislazione, “chi siano i suoi cittadini”), 4 e 7 (che prevedono casi in cui la normativa nazionale includa la perdita della cittadinanza per legge o per sua iniziativa) e 9 (che prevede la facilitazione, da parte di ciascuno Stato contraente, “nei casi e nei modi previsti dalla sua normativa interna” della “reintegrazione nella propria cittadinanza delle persone che la possedevano e che risiedano legalmente e abitualmente nel suo territorio”) della Convenzione europea sulla cittadinanza.
- L’analisi del caso da parte della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha diviso l’analisi del presente caso in due parti.
La prima riguarda la questione e la prima parte della seconda questione. Ricorda che, “secondo una costante giurisprudenza, la determinazione dei modi di acquisizione e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro”, ma osserva anche che “il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest’ultimo”. Già da questo punto si giunge ad un’affermazione importante della Corte: “la situazione di un cittadino dell’Unione che – come il ricorrente nella causa principale – si trovi alle prese con una decisione di revoca della naturalizzazione adottata dalle autorità di uno Stato membro, la quale lo ponga, dopo la perdita della cittadinanza di un altro Stato membro da lui posseduta in origine, in una situazione idonea a cagionare il venir meno dello status conferito dall’art. 17 CE e dei diritti ad esso correlato, ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione”. Afferma, sostanzialmente, che ogni qual volta siano in ballo gli effetti di cui all’art. 17 CE ed i diritti connessi, le conseguenze di una decisione nel merito coinvolge la sfera del diritto UE.
La Corte di giustizia rileva, quindi, la propria competenza a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio riguardanti i presupposti in presenza dei quali un cittadino dell’Unione può, a motivo della perdita della propria cittadinanza, vedersi privato della qualità di cittadino dell’Unione europea, e, di conseguenza, dei diritti a questa connessi. L’esercizio della competenza di attribuzione o revoca della cittadinanza può quindi essere sottoposto “a un controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell’Unione”.
Riguardo al discorso della frode commessa dalla Parte per l’ottenimento della naturalizzazione, la Corte ha fatto presente che una decisione di revoca della stessa per tale ragione può risultare conforme al diritto dell’Unione, in quanto risponde ad un motivo di pubblico interesse. Ritiene “legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini, nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza”.
La Corte di giustizia riscontra conformità anche con il diritto internazionale, analizzando la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia, rilevando che l’art. 8, n. 2 di quest’ultima stabilisce che “una persona può vedersi privata della cittadinanza di uno Stato contraente qualora l’abbia ottenuta mediante false dichiarazioni o qualsiasi atto fraudolento”. Inoltre, la Corte ha rilevato che una decisione di revoca della cittadinanza a motivo della condotta fraudolenta non osta neanche con la Convenzione europea sulla cittadinanza e nemmeno con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Viene rilevato, di conseguenza, che “Tali considerazioni in merito alla legittimità, in via di principio, di una decisione di revoca della naturalizzazione a motivo di atti fraudolenti conservano, di massima, la loro validità nel caso in cui tale revoca determini come conseguenza che l’interessato perda, oltre alla cittadinanza dello Stato membro di naturalizzazione, la cittadinanza dell’Unione”.
La Corte, però, sancisce anche la competenza del giudice del rinvio di verifica del rispetto del principio di proporzionalità riguardo alle conseguenze che una decisione del genere può determinare in rapporto con il diritto dell’Unione, oltre che, eventualmente, all’esame della proporzionalità di tale decisione sotto il profilo del diritto nazionale.
Nell’esaminare una decisione di revoca della naturalizzazione, la Corte ritiene, inoltre, necessario tener conto delle possibili conseguenze che tale decisione comporta per l’interessato, ed eventualmente per i suoi familiari, sotto il profilo della perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione.
Nello specifico, la Corte rileva importante verificare se tale perdita sia giustificata in rapporto: 1) alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato; 2) al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca; 3) alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine.
Riguardo quest’ultimo aspetto, si è ritenuto che lo Stato membro del quale venga acquisita la cittadinanza in modo fraudolento non può ritenersi obbligato, per effetto dell’art. 17 CE, a non revocare la naturalizzazione per il solo fatto che la Parte non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro di origine.
La Corte, inoltre, aggiunge che al giudice nazionale spetta valutare se il rispetto del principio di proporzionalità esiga o meno, prima che la decisione di revoca della naturalizzazione divenga efficace, che venga concesso alla Parte un termine ragionevole per permettergli un tentativo di recuperare la⁰ cittadinanza del suo Stato membro di origine.
La Corte di giustizia risolve la questione dichiarando che l’art. 17 CE “non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione la cittadinanza acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità”.
Riguardo la seconda parte dell’analisi del caso, il giudice del rinvio chiede se lo Stato membro di cui la Parte possedeva in origine la cittadinanza abbia o meno l’obbligo di effettuare un’interpretazione della propria normativa nazionale, per evitare la perdita della cittadinanza dell’Unione, permettendo quindi alla stessa il recupero della cittadinanza originaria.
Nel merito, la Corte rileva che i principi emersi nella presente sentenza si applicano sia allo Stato membro di naturalizzazione che allo Stato membro di cittadinanza originaria, ma rileva anche che la revoca della naturalizzazione acquisita in Germania ancora non è divenuta definitiva. Con ciò, la Corte ritiene che non si possa pronunciare sulla questione in mancanza di una sentenza definitiva, rilevando la competenza delle Autorità austriache ad adottare la decisione e a valutare la regolarità della stessa.
- La pronuncia
In conclusione, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha, conseguentemente alla sopracitata analisi, dichiarato che “Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità”.
A cura di: Antonio Natale
Fonti
- “Elementi di diritto dell’Unione Europea” di Adelina Adinolfi e Claudia Morviducci, Ed. Giappichelli.
- Sentenza Rottmann: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0135
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
- Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
- Per l’immagine: Foto di Ralph da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/migrazione-integrazione-migranti-3129387/)